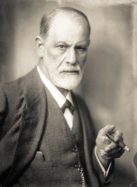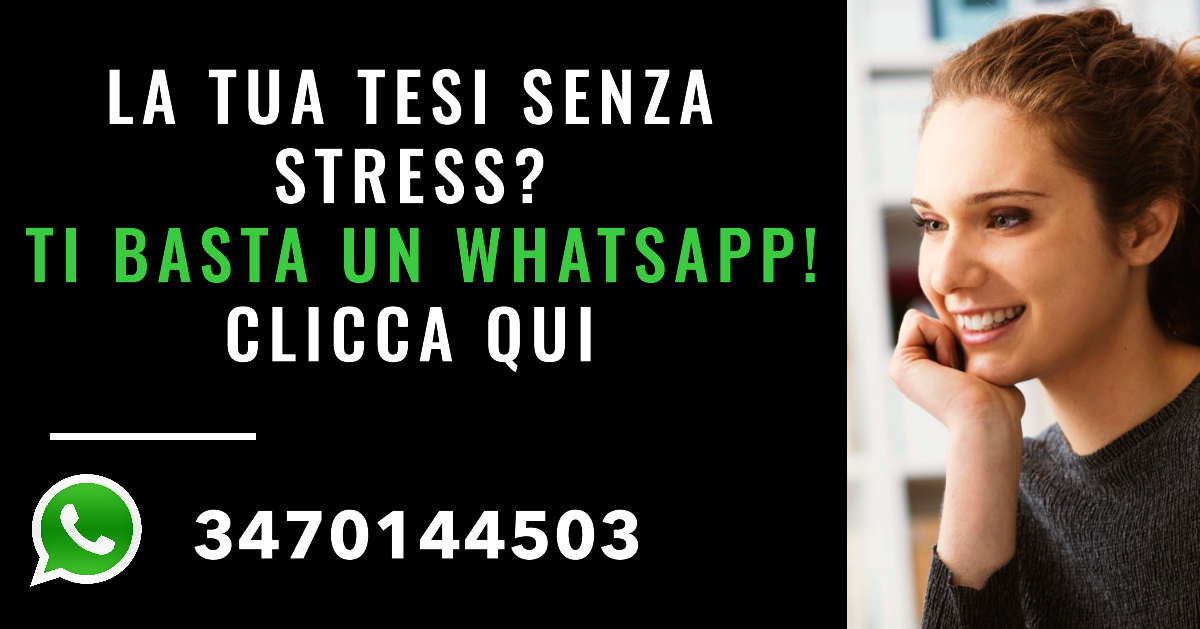Spesso è stato motivo di dibattito, tra coloro che si occupano di psicoanalisi, definire esattamente la natura, i limiti ed i precisi ambiti di applicazione di questa disciplina. In particolare si è molto discusso su quanto fosse corretta la posizione di chi, considerando preminenti gli aspetti clinici e terapeutici della psicoanalisi, pone in secondo piano il valore delle riflessioni e degli studi (sull’arte, l’etnologia, la sociologia o la religione) che sono solitamente raggruppati nel grande capitolo delle ‘applicazioni della psicoanalisi’. Poiché Freud era medico ed iniziò le sue ricerche in un ambito volto esplicitamente alla cura dei pazienti isterici, sono in molti a ritenere che questo dato basti di per sé a qualificare la psicoanalisi essenzialmente come psicopatologia e trattamento terapeutico […] Sottolineare l’importanza delle applicazioni della psicoanalisi a contesti differenti da quelli strettamente clinici e terapeutici porta con sé due conseguenze importanti: in primo luogo quello clinicoterapeutico diventa solo uno degli ambiti applicativi della psicoanalisi, intesa più genericamente come strumento di conoscenza della realtà ; in secondo luogo, per quanto attiene specificamente all’ambito clinico, il momento conoscitivo risulta preponderante rispetto a quello trasformativo.
Che cosa ritorna in Freud se non la non nominata filosofia? E la collocazione dell’interesse per la filosofia in quel momento originario che si scopre come tale solo successivamente, non è forse per Freud il modo più sottile di indicare che il rapporto della psicoanalisi alla filosofia non è altra cosa rispetto al riconoscimento di una originaria coappartenenza reciproca? Il Poscritto esplicita, d’altro canto, tutta l’ambiguità freudiana rispetto al rapporto della psicoanalisi con la filosofia, un’ambiguità tanto critica quanto produttiva se il ritorno al “mondo del pensiero” viene autoriflessivamente esibito e al contempo minimizzato.