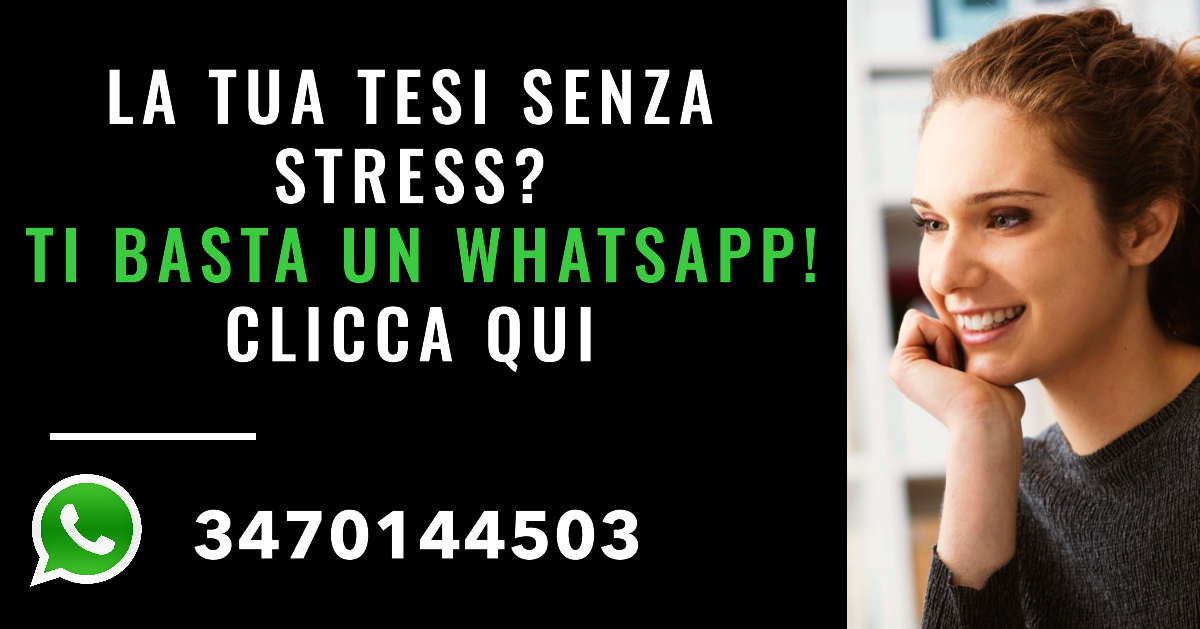La psicoanalisi è ormai da tempo riconosciuta come una delle espressioni fondamentali del XX secolo .
Nonostante sia stata avversata sin dall’inizio, come ogni rivoluzione di pensiero, e lo sia a tratti anche oggi, la psicoanalisi ha avuto un’ enorme influenza sulla nostra cultura quasi a tutti i livelli, sottraendosi così, progressivamente, allo status di pura teoria medico-scientifica o di pratica esclusivamente terapeutica.
Ben al di là degli scritti più dichiaratamente teorici, infatti, tutta l’opera di Sigmund Freud, anche quella clinica, possiede un autonomo e imprescindibile valore filosofico , antropologico e pedagogico generale . Non è certo un caso che Freud stesso abbia sempre tentato di trarre conseguenze più vaste rispetto al significato iniziale della psicoanalisi come teoria delle nevrosi e dei disturbi psichici . Da questo punto di vista, gli sviluppi della sua opera e di quella dei suoi allievi hanno nel tempo generato un allargamento del le tematiche psicoanalitiche verso altri aspetti della cultura contemporanea.
Elementi tratti dalla psicoanalisi, oltre a vere e proprie applicazioni di essa, si trovano infatti tuttora in psichiatria, sociologia, antropologia culturale , oltre che, naturalmente, all’interno di nuove ipotesi cliniche sui disturbi psichici.
Da Freud in poi, in altre parole, si può tranquillamente affermare che gli studi sull’origine dello sviluppo della personalità umana, delle sue patologie, dei suoi lati inconsci, gli studi sulla sessualità, il rapporto individuo -società, il senso della dimensione religiosa, non possano quasi più prescindere dalle acquisizioni fondamentali della teoria di Freud, al di là dei giudizi su singole parti di essa o sulla sua complessa validità scientifica.
In questo articolo parliamo di Freud e del ribaltamento antropologico che ha causato con le sue teorie sulla psiche umana e sulla psicoanalisi nei primi anni del Novecento.